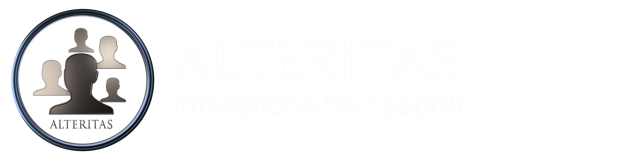6 novembre 2012. Seminario Vescovile, aula sede Alteritas, ore 9:30-13:00
Seminario di studi organizzato dal Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine e Società (TeSIS) in collaborazione con Alteritas
Clerici peregrini. Indagini sulla mobilità del clero nel basso medioevo.

Relatori:
Andreas Rehberg (Istituto Storico Germanico, Roma): Religiosi e chierici stranieri a Roma nel medioevo
Emanuele Curzel (Università di Trento): Mobilità del clero nella regione alpina. Appunti a partire dal caso trentino.
Mariaclara Rossi (con la collaborazione di Alessia Martinelli e Lorenzo Perlini): Chierici di Levante nelle diocesi venete del Tre-Quattrocento.
Moderatore: Donato Gallo (Università di Padova)
Il seminario si è proposto di approfondire, attraverso alcune indagini avviate in contesti ‘locali’ – Roma, l’area trentina e le diocesi della Terraferma Veneta – il fenomeno dell’itineranza di chierici e religiosi nel basso medioevo. Fin dai primi secoli della cristianità infatti la presenza dei vagantes, si trattasse di monaci oppure di chierici, aveva destato nelle autorità ecclesiastiche una profonda diffidenza, poiché la consuetudine della peregrinatio poteva mettere a rischio i concetti di obbedienza e autorità, su cui la Chiesa aveva, almeno in parte, costruito la sua identità.
Tali timori e preoccupazioni crebbero nel corso del medioevo, quando le migrazioni e il vagabondaggio diventarono, come è noto, un comportamento assai diffuso, rendendo necessarie, da parte dei vescovi, forme di controllo e di disciplinamento dei flussi di chierici e monaci che per motivazioni e con obiettivi diversificati percorrevano l’intera cristianità.
L’interesse storiografico verso il tema della mobilità del clero è piuttosto recente e si abbina a un’accresciuta curiosità verso i temi delle migrazioni, delle vie di comunicazione e soprattutto verso il tema degli scambi culturali, dell’ ‘integrazione’ e dell’ ‘acculturazione’. Ieri come oggi, Roma si presenta ovviamente come un singolare laboratorio per le indagini su questi argomenti, anche perché il viaggio o la permanenza nella Città eterna venivano considerati ‘meritevoli per la salvezza dell’anima, fonti di spiritualità e tappe sulla via della perfezione’. Tuttavia oltre alla fondamentale direttrice ‘da’ e ‘verso’ la città del Papa, si deve considerare anche il ruolo di altre importanti ‘rotte’ – ugualmente percorse da chierici e monaci – che mettevano in comunicazione e in dialogo le società e le culture del Mediterraneo. Nello specifico, risulta consistente durante basso medioevo la presenza a Venezia e in molte città dell’Italia settentrionale di esponenti del clero orientale, proveniente dai territori dell’impero bizantino, progressivamente minacciati dall’avanzata turca, e di esponenti provenienti da un Oriente più familiare e vicino, quello dei Balcani e dell’Europa orientale. Lo studio di queste figure, del loro ruolo e delle vicende legate al loro soggiorno a Venezia e nelle città dell’entroterra veneto potrebbero costituire un punto di osservazione importante per gettare una luce sui rapporti fra una sponda e l’altra dell’Adriatico.